L'illusione dell'immortalità

Sentirsi immortali è forse da sempre tra le prerogative della giovinezza, e anche tra i privilegi. Scrivo forse perché nell’età classica, quando gli antichi si riferivano agli uomini, li chiamavano mortali.
L’ immortalità era infatti un’esclusiva degli dèi, e non la si inseguiva a colpi di chirurgia plastica. Oggi una tale proprietà di linguaggio è per noi inconcepibile: in questo nostro eterno presente privo di dèi, la morte è il solo vero tabù rimasto. Tuttavia, un conto è vivere nell’illusione dell’immortalità quando si ha la fortuna - oppure la sfortuna, dipende dai punti di vista - di condurre un’esistenza più o meno normale. Un altro è farlo quando per mestiere si rischia la vita ogni singolo giorno, o quasi. Marco Simoncelli, che pure non era né un soldato né un volontario del soccorso alpino, faceva un mestiere così. Perché nonostante tutto ciò che si è fatto per aumentare la sicurezza dei centauri, e malgrado gli incidenti mortali siano rari, il motociclismo resta uno sport pericoloso. E chi lo pratica a certi livelli non può non esserne consapevole. Marco Simoncelli, pur con tutta l’esuberanza dei suoi ventiquattro anni, la sua aria scanzonata e il fare un po’ guascone, lo era certamente. Ma a chi evocava in sua presenza la possibilità di morire in un incidente e voleva sapere se da parte sua avesse mai paura, ribatteva con l’acceleratore aperto: «No, si vive di più andando cinque minuti al massimo su una moto come questa di quanto non faccia certa gente in una vita intera». Dichiarazione di puro vitalismo che sarebbe piaciuta, più che al Vasco Rossi di Una vita spericolata «alla Steve McQueen», a Ernest Hemingway, uno che aveva smesso di sentirsi immortale quand’era stato ferito sul Carso appena diciannovenne, e che da quell’istante era stato ossessionato dal pensiero della morte, non a caso dedicando ai toreri, che per mestiere sfidavano «l’eterna puta», il suo Morte nel pomeriggio. Ecco: proprio come un torero, ma senza spargere sangue di animali di razza Miura, anche Marco Simoncelli detto Super Sic era pagato per dare spettacolo sfidando la morte. Cosa che noi, pubblico collegato via satellite con il circuito dell’ultima gara, tendiamo molto spesso a dimenticare. Non solo per il processo di rimozione del tabù di cui sopra, ma perché certe stelle dello sport, così esuberanti, così simpatiche, ci appaiono immortali per forza di cose. In realtà, come accade sempre in questi casi, si tratti non solo di sportivi ma anche di rockstar, attori o simili, solo ora che è morto a ventiquattro anni Marco Simoncelli detto Super Sic è diventato davvero immortale. La sua morte, inaccettabile per i genitori com’è sempre quella di un figlio, è la morte di un ragazzo che ha avuto il coraggio e la capacità e la fortuna di costruirsi la vita che desiderava. «È da quando ero piccolo che sognavo di andare in MotoGp», raccontava in un’intervista finita su YouTube. Per tornare agli antichi, scriveva Menandro: «Muor giovane colui che al cielo è caro». È, questa, l’unica consolazione per chi resta. Oltre al fatto di sapere che Marco è vissuto esattamente come voleva, e che da qualche parte dentro di sé doveva aver messo in conto che vivere come si vuole costa molto più di quanto la maggior parte di noi sia disposta a pagare.
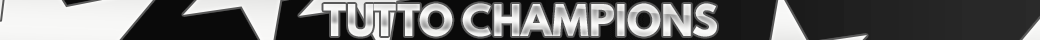










 Dave Murru è stato intervistato in esclusiva da TorinoGranata.it. Dave è il chitarrista della band...
Dave Murru è stato intervistato in esclusiva da TorinoGranata.it. Dave è il chitarrista della band...
 La priorità di Vagnati per gennaio sarà l’acquisto di una punta, però a Vanoli serve anche un...
La priorità di Vagnati per gennaio sarà l’acquisto di una punta, però a Vanoli serve anche un...
 L’Empoli è a tre punti dall’Europa e si coccola Roberto D’Aversa, artefice dello splendido girone di...
L’Empoli è a tre punti dall’Europa e si coccola Roberto D’Aversa, artefice dello splendido girone di...
 UNDER 18 - Importante successo per la squadra di Christian Fioratti che nel quattordicesimo turno di campionato ha liquidato con un perentorio 4-1 i pari età dell'Atalanta. Dopo il gol di Gallo e con il primo tempo che è poi terminato 1-1, nella ripresa la...
UNDER 18 - Importante successo per la squadra di Christian Fioratti che nel quattordicesimo turno di campionato ha liquidato con un perentorio 4-1 i pari età dell'Atalanta. Dopo il gol di Gallo e con il primo tempo che è poi terminato 1-1, nella ripresa la...
 Le festività natalizie si avvicinano e passare qualche minuto spensierati e facendosi belle risate fa bene e allora ecco i divertenti, ormai consueti, auguri fatti dalla band Sensounico. Per i tifosi del Toro e anche per chi tifa altre squadre o proprio non è...
Le festività natalizie si avvicinano e passare qualche minuto spensierati e facendosi belle risate fa bene e allora ecco i divertenti, ormai consueti, auguri fatti dalla band Sensounico. Per i tifosi del Toro e anche per chi tifa altre squadre o proprio non è...
