L'ultimo giorno di Gigi Meroni

Nel mio cielo stellato, la luce di Gigi Meroni non conosce eclissi. Il suo astro ravviva la memoria negli anziani, e il suo estro attizza la fantasia dei posteri, nell’impari confronto tra il dover immaginare un passo di danza e l’aver sgranato gli occhi mentre avveniva.
I Genoani di allora gli avevano affidato il futuro, che lui ricamava sul prato, finché un giorno il dio dei debiti e delle plusvalenze ne reclamò il possesso, requisendolo sul più bello. Al timone c’era Berrino, ma con Fossati o Spinelli sarebbe stato lo stesso, per non dire dell’allievo Preziosi che oggi sta superando i maestri nell’arte di piazzare i campioni.
Meroni era uno spettacolo a sé, un artista di strada che ammaliava le folle e, grazie a lui, ogni vigilia della partita diventava una veglia di dolci presagi. Ricordo i sussulti della gente quando Gigi riceveva il pallone, perché era fatale che inventasse qualcosa, e c’era chi arrivava a inveire contro il giocatore che gli avesse negato il passaggio.
A volte, quando puntava a rete, la Nord l’accompagnava in un crescendo vocale, come alla Plaza de Toros, e lui scansava le incornate dei terzini per piantare la banderilla oltre la riga.
Il campionato 1963/64 fu una collana di perle indelebili, come i due goal alla Fiorentina, o quello a Bari dopo uno slalom pazzesco, o la memorabile rete al Mantova di cui le foto ci consegnano la resa di Schnellinger e il volto esterrefatto del giovane Zoff, appena dribblato.
Ma il goal, pur fondamentale, era un di più, perché la vera goduria consisteva nei tocchi e nelle movenze: il prestigiatore cavava dal cappello… non l’ormai prevedibile coniglio, ma un vero “sarchiapone” in carne e ossa, perché nel suo repertorio c’erano cose mai viste prima.
Il contrasto che più risaltava in lui era il coraggio spavaldo rispetto all’esilità del fisico, come se la robustezza dei difensori non lo riguardasse, perché nel frattempo sgusciava via.
Non è il caso di santificare Meroni, perché non sempre gli venivano con il buco.
A volte, invece di esibirsi in un travolgente beat tirava fuori un’inconcludente milonga, oppure tirava fuori e basta, ma bisogna considerare quanta attesa si portava addosso perché i Genoani, senza dirglielo, gli avevano affidato il riscatto delle proprie frustrazioni, e forse non solo calcistiche.
Anche per questo la sua partenza fu un trauma: improvvisa come i colpi di stato, amara come i tradimenti, irreversibile come un divorzio, cupa come la notte.
Con la sua aria da scapigliato e romantico bohemien faceva ammattire le difese più agguerrite, e in quella tenzone c’era la metafora e la sfida leale che uno schivo introverso imprevedibile folletto portava all’ipocrita bacchettona e vischiosa società del suo tempo.
Purtroppo non riuscì ad accogliere il 1968, il furioso giustiziere di tanti pregiudizi ma, le schegge della sua ribellione alle regole omologate, pungevano i bigotti del calcio e i templari del conformismo.
Però non confondeva la forma con la sostanza, e compensava il rigore professionale con le stranezze del privato.
Amava dipingere, ma era uno strano pittore che alla domenica diventava poeta, e i suoi versi sfioravano appena l’erba, come un aliscafo sulle onde del mare.
Luigi era orgoglioso dell’affetto che percepiva intorno a sé, anche se in qualche modo ne era intimidito.
Un qualunque sbruffone del teatrino del calcio avrebbe sfruttato quella ribalta per pavoneggiarsi in interviste tutte uguali ma lui, che tanto concedeva alla platea, ripiegava dietro le quinte appena il clamore si faceva insopportabile.
Cercava il sapore della vita nell’improvvisazione, per acchiappare il momento, per abolire i programmi e sfidare l’incerto, ma con semplicità, e senza scordare l’umiltà delle origini.
Anche il rapporto verso la Nazionale fu controverso, con il Ct Fabbri che lo convoca ma gli fa tagliare i capelli come alle reclute in caserma, che lo porta ai mondiali del 66 ma non lo schiera nella partita chiave (evitandogli così la vergogna della sconfitta Coreana), quello stesso Fabbri che di lì a poco sarebbe diventato il suo allenatore al Torino.
Si racconta anche un curioso episodio del 1964, il suo patto segreto con Beniamino Santos: “Mister, se io aiuto il Genoa a salvarsi, poi mi fa ingessare una gamba? Sa, pare mi chiamino in Nazionale, ma io voglio stare con Cristiana, gliel’ho promesso”.
Luigi amava i Beatles, li citava come fossero vecchi amici, e infatti per il look si ispirava a Ringo Starr.
Evocava il Jazz come simbolo della libertà di espressione, perché tutto ciò che squinternava i protocolli gli piaceva, ed era rimasto molto colpito dalla morte di Che Guevara avvenuta solo pochi giorni prima della sua fine.
Rimuginava sui misteri del mancato (e sgradito) trasferimento alla Juve, già deciso e poi annullato, e sussurrava agli amici la leggenda dei sabotaggi alla catena di montaggio della Fiat 128 da parte di operai granata in allarme.
Aveva in mente la curiosa assonanza fra i suoi 24 anni e i 24 goal segnati con la maglia del Toro, e sperava di non dover aspettare un anno per realizzare il 25°.
Forse era per questo che, da qualche tempo, Mister Fabbri gli faceva tirare i rigori, come a Brescia dove aveva segnato la sua ultima rete; eppure lui li detestava, perché gli sembravano un’antipatica scorciatoia per il goal, addirittura blasfema rispetto al suo modo frizzante di intendere il gioco.
Se il calciatore Meroni resterà immortale, l’uomo ha dovuto invece obbedire ai disegni, anzi agli scarabocchi, del fato: assemblando qualche vago frammento di cronaca, si possono immaginare i pensieri di quell’ultimo suo giorno, il 15 ottobre 1967.
Quella sera Luigi era al ristorante; aveva telefonato alla sua Cristiana per avvertirla che stava arrivando, e lei apprezzò il gesto perché si sentiva sola, anche più di quanto non fosse, visto che avevano appena traslocato e il disordine della casa era tale da ricordarle quel Luna Park in cui era cresciuta: ora convivevano, tra lo scandalo dei benpensanti e il furore del marito di lei.
S’incamminò per Corso Re Umberto insieme all’amico Poletti, gustando un gelato e discutendo sulla partita con la Sampdoria giocata nel pomeriggio, vinta per 4-2 ma senza entusiasmare.
Chissà, forse quel nome sgradevole gli fece tornare alla mente i derby di Genova, e magari raccontò a Fabrizio la sua esperienza in rossoblu… i goal tutti speciali… l’affetto dei Genoani… il tragico incidente stradale in cui era morto Beniamino Santos, e che i giornali avevano in qualche modo collegato alla sua repentina cessione.
Approfittando del traffico intermittente, i due ragazzi si portarono al centro strada e, per una curiosa assonanza, Luigi si trovò con i piedi sulla riga bianca fra le corsie, così simile a quella dell’out che lui, da ala destra, era da sempre abituato a non oltrepassare. Sarà che forse si sentiva a suo agio, ma cominciò un’impercettibile danza fra le auto che, poco prima, erano ripartite tutte insieme al verde del semaforo.
Poco prima, il futuro presidente del “Torino Calcio” Attilio Romero era salito in macchina per andare a cena.
Le ragazze lo definivano un tipo “interessante”, e questa era la prova che non fosse bello, ma la sua cultura e il suo denaro gli garantivano un certo successo.
Fin dalle elementari lo avevano accusato di essere un opportunista, ma lui non era il tipo da rubare le merendine e le banane agli altri bambini: se mai li convinceva, in qualche modo, a dargliele.
Pur così giovane tra poco sarebbe entrato, e dalla porta principale, in una grande azienda, ma non poteva dir quale perché poco intonata alla sua fede calcistica… però la si poteva immaginare: lui, Granata sfegatato, teneva sul cruscotto la foto dell’idolo Meroni, anche se mancava la classica frase… “vai piano, non correre, pensa a me”.
Quella sera, i semafori erano tutti rossi e rischiava di far tardi, ma non era impaziente, anche perché ormai l’auto gliela stava guidando il destino.
Poi finalmente arrivò il verde.
Gigi Meroni e Attilio Romero si stavano attraendo inconsapevolmente, senza motivo, in un appuntamento senza ragione.
Attilio vide due ombre uscire dal buio e implorargli di frenare.
Luigi cercò di dribblare quei due fanali che lo stavano puntando, ma aveva piovuto e tutto luccicava; lui stesso era soltanto un riflesso in più su quell’asfalto lucido. L’auto di Attilio, come fanno i terzinacci in serie C, entrò a scivolone in un tremendo impatto e l’arbitro, che non poteva influenzare il risultato, fischiò tre volte e decretò la fine.
E fu la fine.
Con il cinismo di cui è capace, la sorte aveva assegnato a Gigi il ruolo di bersaglio, e ad Attilio l’imperituro zaino del senso di colpa. Quasi 20 anni prima, sulla collina di Superga, si schiantava l’aereo del Grande Torino; il pilota doveva atterrare a Milano ma, per motivi sconosciuti, cambiò idea e scelse Torino: il suo nome era PierLuigi Meroni, un’omonimia sconvolgente.
Gigi era un’ala destra, non una macchina da cross; non somigliava a quelli che oggi chiamiamo esterni o cursori di fascia; non faceva il terzino aggiunto; non aveva movimenti obbligati e porzioni di campo imposte; sul petto portava il Grifone e non una marca di biscotti; sulla schiena aveva il 7 e non il 37 o il 57; al goal non si esibiva in strazianti coreografie, ma alzava le braccia al cielo, con la semplicità dei grandi. No, lui era genio e fantasia, e trasformava il pallone di cuoio in un magico caleidoscopio di vetro.
Addio Gigi.
Ti hanno chiamato farfalla per la leggerezza del tuo tocco e per i colori del tuo estro, ma forse il vero motivo è un altro: come le farfalle, tu hai vissuto soltanto pochi attimi dell’infinito.
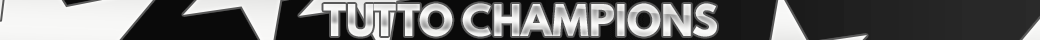


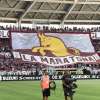







 Dave Murru è stato intervistato in esclusiva da TorinoGranata.it. Dave è il chitarrista della band...
Dave Murru è stato intervistato in esclusiva da TorinoGranata.it. Dave è il chitarrista della band...
 La squadra tedesca si trova in difficoltà a causa dei portieri. Neuer è infortunato ad una costola, che...
La squadra tedesca si trova in difficoltà a causa dei portieri. Neuer è infortunato ad una costola, che...
 L'Atalanta perde ma lo fa a testa altissima contro il Real Madrid di Carletto Ancelotti, un 2-3 maturato nella ripresa...
L'Atalanta perde ma lo fa a testa altissima contro il Real Madrid di Carletto Ancelotti, un 2-3 maturato nella ripresa...
 UNDER 18 - Importante successo per la squadra di Christian Fioratti che nel quattordicesimo turno di campionato ha liquidato con un perentorio 4-1 i pari età dell'Atalanta. Dopo il gol di Gallo e con il primo tempo che è poi terminato 1-1, nella ripresa la...
UNDER 18 - Importante successo per la squadra di Christian Fioratti che nel quattordicesimo turno di campionato ha liquidato con un perentorio 4-1 i pari età dell'Atalanta. Dopo il gol di Gallo e con il primo tempo che è poi terminato 1-1, nella ripresa la...
